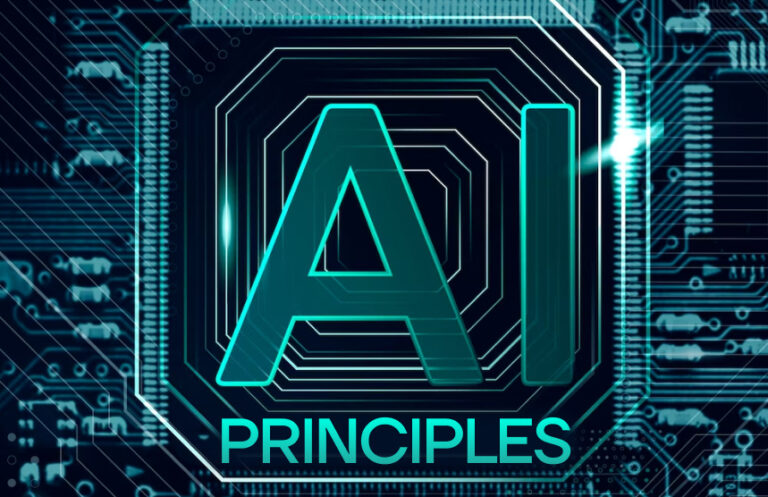Chi salverà i giornali? Ecco i business model possibili
 Come ogni crisi, anche quella del modello basato unicamente sulla pubblicità , offre opportunità interessanti – Attraverso una serie di interventi apparsi su ‘’Monday Note’’ le ragioni della crisi dell’advertising model e la sperimentazione di nuovi modelli di business, tra cui il tanto osteggiato paid-for model – Le dicotomie che caratterizzano il panorama attuale: Open-Close, Free-Paid – L’ esperienza di Apple e il fenomeno iTunes – La sostenibilità di un modello a pagamento in un panel online organizzato dalla CUNY con la partecipazione, tra gli altri, di Jaff Jervis
Come ogni crisi, anche quella del modello basato unicamente sulla pubblicità , offre opportunità interessanti – Attraverso una serie di interventi apparsi su ‘’Monday Note’’ le ragioni della crisi dell’advertising model e la sperimentazione di nuovi modelli di business, tra cui il tanto osteggiato paid-for model – Le dicotomie che caratterizzano il panorama attuale: Open-Close, Free-Paid – L’ esperienza di Apple e il fenomeno iTunes – La sostenibilità di un modello a pagamento in un panel online organizzato dalla CUNY con la partecipazione, tra gli altri, di Jaff Jervis
———-
di Andrea Fama
La caduta degli dei
Secondo Frédéric Filloux di Monday Note, la pubblicità on-line “fa schifo” e la maggior parte delle campagne sono solo un incentivo ad installare un AdBlock software. Vista così, non c’è da meravigliarsi se il business model fondato solo sulla pubblicità (che finora ha imperato su Internet) stia gradualmente disgregandosi lasciando emergere dubbi strategici, errori di valutazione e nuove prospettive di business. E che l’advertising on-line sia in crisi (sebbene in Italia il trend sia ancora positivo) lo dicono i numeri.
– La crescita dei volumi pubblicitari, se ci sarà, sarà minima. Negli U.S.A., ad esempio, si è registrata una crescita del 10,6% (il peggior risultato dal 2002), e secondo le previsioni Nielsen il 2009 vedrà una contrazione drammatica, portando il volume di crescita al 4,6%.
– I prezzi sono in caduta libera. In Francia, molti grandi siti sono passati da 10€ CPM (cost per thousand impression) a 7 o 8€. L’azienda di marketing PubMatic prevede una contrazione del 48% del CPM tra l’ultimo trimestre 2008 e il periodo corrispettivo nel 2009.
– Più crescono gli spazi, più scendono i prezzi. Quest’anno molti siti svenderanno circa il 50% dei propri spazi pubblicitari invenduti ai network pubblicitari.
– Il click-through-rate non cresce, superato dalla formula pay-for-performance che abbatte ulteriormente le entrate.
Anche i principali modelli di advertising (vedi grafico – fonte IAB) sono a rischio o stanno subendo sostanziali cambiamenti.
– Banner: diminuiscono sempre più (per mancanza di budget adeguati, creatività, trageting) a tutto vantaggio del search advertising;
– Classified Ads (o piccoli annunci/annunci classificati): segnati dal rallentamento economico, nel 2008 hanno registrato un – 4%, con previsioni al ribasso per il 2009.
– Search: è il formato che incassa (oltre il 50% quest’anno) e cresce di più (+20% nel 2008, crescita doppia rispetto all’intero settore), ma tali performance comportano prezzi in caduta e un tornaconto economico che penalizza i siti a favore di Google (leader incontrastato con il 70% del mercato secondo eMarketer).
Google stessa, però, che fonda il proprio network pubblicitario sul sistema AdWords (2/3 delle entrate) e sul programma AdSense (1/3 delle entrate), risente della crisi di settore, registrando crescite notevolmente ridotte rispetto agli anni precedenti (vedi grafico).
Inoltre, se Google paga la crisi del mercato pubblicitario, molto peggio va ai media partner di Mountain View, che ricevono una fetta decisamente meno sostanziosa dell’intero volume d’affari realizzato da Big G. Conseguentemente, specie i siti più piccoli, che non ospitano un gran numero di inserzioni pubblicitarie e quindi non possono godere di alcun tipo di economia di scala, si ritrovano oggi spalle al muro, e in questa scomoda posizione si interrogano sull’effettiva bontà dei propri investimenti.
Cosa ha determinato il fallimento dell’advertising model?
Ancora Frédéric Filloux, in un altro intervento su Monday Note, sostiene che vi è una contraddizione interna al modo di progettare i siti Web e al conseguente inserimento della pubblicità. E l’errore, continua Filloux, è dovuto al fatto che sul Web si adotta l’impostazione dei giornali tradizionali senza tenere conto che sui due mezzi la fruizione dell’informazione è differente. Innanzitutto, la soglia dell’attenzione on-line è molto più bassa (gli utenti trascorrono 15 minuti al mese sul sito del New York Times, o Le Monde piuttosto che Le Figaro, mentre i lettori ne passano 25/35 al giorno sulla versione cartacea), e quindi gli spazi pubblicitari vanno gestiti diversamente. Mentre su carta la pubblicità è una tappa accattivante del viaggio informativo, sul Web “non c’è spazio per i fronzoli”. Inoltre, a causa dei budget bassi (che non consentono location o testimonial allettanti) le agenzie considerano il web advertising come un “genere minore” e, tra le altre cose, non vi associano un media planning adeguato.
Cosa si può fare quindi per ovviare a questa situazione? Secondo Filloux un primo passo sarebbe riunire un panel di addetti ai lavori, tra cui web designer, creativi pubblicitari, editor, uomini di marketing e rappresentanti del web nella stessa stanza per far uscire qualche idea analizzando vari aspetti: studi comportamentali, modalità di navigazione e di visualizzazione dello schermo da parte degli utenti, ultime novità sulla creazione di pagine Web e sul linguaggio Flash, tanto per citarne alcuni.
In secondo luogo, si potrebbe puntare su un targeting molto più accurato (conoscete qualcuno che abbia mai cliccato su uno degli avvisi segnalati sulle pagine di Gmail?), basato su un panel di centinaia di migliaia di utenti e sui rispettivi dati socio-demografici, nonché su un algoritmo lessicale che raggruppi le parole nel modo migliore. In pratica, tutto ciò che Google sta cercando di sviluppare sul settore.
Il terzo punto da affrontare riguarda le inventory, ovvero le innumerevoli pagine che ogni giorno arricchiscono il Web e si candidano come legittimi spazi pubblicitari, abbassando conseguentemente il prezzo delle inserzioni in virtù di una quantità pressoché incolmabile di spazio.
Secondo Filloux, in questo caso la soluzione è una sola: non vendere più le pagine pubblicitarie al di sotto di determinate cifre (politica a quanto pare adottata da Yahoo). È una mossa coraggiosa, kamikaze per certi versi, ma rappresenta l’unica strada percorribile.
In ultima analisi, Filloux propone di modificare il business model dei siti produttori di contenuti, rispolverando un’idea che oggi sembra essere tornata prepotentemente in auge: la fruizione a pagamento. Oltre a Murdoch, infatti, sono diversi gli editori che, insieme, stanno tentando di concertare una strategia efficace in merito. Questa è una strada che è già stata battuta, e non sempre con successo. Secondo Filloux il modello che emergerà sarà quello del 20/80, ovvero il 20% degli utenti che pagano un piccolo contributo e garantiscono un accesso libero al restante 80%. Ciò permetterebbe anche di migliorare la gestione dell’advertising, garantendo un prezzo standard per l’audience normale e tariffe più elevate per quello targettizzato, maggiormente coinvolto e quindi più interessato.
A questo punto, però, la domanda da porsi è: dove verrà eretta la barriera del pagamento? Secondo Bruno Platino, creatore del sito Le Monde Interactive, “la questione non è più su quali contenuti sono da considerarsi premium e quali gratuiti. La linea, infatti, va tracciata a seconda dell’utilizzo di Internet. Gli utenti assidui pagheranno, quelli occasionali no. Questo è quanto”. Ma, aggiunge Filloux, si potrebbe tracciare un’altra linea che separi i siti che, in virtù di archivi e data base molto ampli, consentono un uso massiccio del proprio portale e quelli destinati a rimanere gratuiti a causa di una storia più recente e di redazioni più smilze e, quindi, con meno materiale consultabile.
Il modello a pagamento
Come ogni crisi, dunque, anche quella dell’advertising model presenta nuove, interessanti opportunità da cogliere per un modello di business sostenibile. Sempre Filloux sostiene che la dicotomia sistema chiuso/aperto, modello a pagamento/gratuito è una vera e propria guerra di religione, e che il futuro sembra risiedere nel modello ibrido.
Riguardo il sistema aperto o chiuso dei siti, Filloux evidenzia l’importanza strategica di un programma come l’API (cui LSDI aveva già dedicato un approfondimento) che, invece di fornire i link per una pagina statica del sito, consente un accesso live al data-base dello stesso. L’API, che tra l’altro ha costi marginali, presenta una controindicazione: come in precedenza, si addice quasi unicamente a quei media in grado di sfruttare la “lunga coda” dei propri contenuti distintivi, ovvero quei media in possesso di archivi vasti e di qualità, tipici delle redazioni tradizionali e non di un blog gestito da una decina di smanettoni, per quanto svegli. Inoltre, l’adozione di un programma con queste caratteristiche suppone una determinata cultura ed apertura mentale da parte dell’editore (pensiamo al deep-linking, che consente di spedire un utente all’interno di un sito, anche se la pagina linkata si trova oltre il paid wall, la barriera del pagamento).
Ebbene, questa è un’attitudine già sviluppata nel mondo anglofono (Guardian, Economist, New York Times hanno già adottato il programma), ma ancora osteggiata in Europa (Le Monde, ad esempio, non consente il deep-linking neanche verso i propri contenuti gratuiti).
Sebbene l’API e la disseminazione dei propri contenuti non siano una panacea per gli editori, quantomeno consentono di ottimizzare le entrate pubblicitarie, e costituiscono un investimento nel capitale intellettuale del brand.
Perché il modello a pagamento funzioni, invece, bisogna che soddisfi tre condizioni:
- I grandi editori devono saper bilanciare i contenuti gratuiti (che attirano masse di utenti) e quelli monetizzabili (che costituiscono il valore aggiunto del sito);
- Il sistema di pagamento deve trasformarsi in un’aggregazione di micro-pagamenti, rapidi e semplici, in modo da far corrispondere il “costo mentale” della transazione al basso costo monetario della stessa;
- Le piattaforme tecnologiche devono essere più performanti (e in questo senso sembra che Kindle piuttosto che iPhone abbiano imbroccato la strada giusta, grazie ad applicazioni avanzate, alla connessione wireless, ad una maggiore resistenza degli apparecchi e ad una maggiore durata delle batterie, ad esempio).
What would Apple do (or actually did)
Quando si parla di paid-for model e di micro-pagamenti, invariabilmente salta fuori il casoiTunes. Per alcuni, infatti, i micro-pagamenti sono una cattiva idea, peraltro vecchia; per altri, invece, il caso iTunes (1 miliardo di canzoni vendute a febbraio 2006, 3 miliardi a luglio 2007, 5 miliardi a giugno 2008 e 6 miliardi a gennaio 2009) è, almeno in parte, replicabile e può essere adottato da altre aziende.
A pensarla così è Jean-Louis Gasse, sempre su Monday Note, secondo cui ad eccezione dello stile inimitabile della Apple e del proliferare di spazi in stile AppStore, ciò che ha veramente aperto la strada al fenomeno iTunes è stato abbassare proprio il costo mentale della transazione. Una volta creato un account, infatti, si può acquistare una canzone con un solo click, senza dover continuamente riempire moduli con i propri dati personali ad ogni acquisto. E lo stesso fa Amazon, mentre eBay adotta altri sistemi – più complicati e in un certo senso deterrenti – poiché non ha il controllo diretto su ‘chi mette in vendita cosa’.
Una delle obiezioni mosse dai detrattori del modello iTunes è che Apple deve aver strappato un accordo irripetibile con fornitori di carte di credito, considerati i pagamenti da 99 centesimi. Tutto vero. Bisogna considerare, però, che inizialmente Apple non pensava che iTunes potesse essere un business trainante, ma piuttosto un modo per spingere le vendite dell’iPod, che garantiscono un margine maggiore. La nascita degli AppStore, però, ha fatto sì che Apple fosse in grado di ricreare un ambiente in cui l’utente è ben disposto a pagare per un prodotto o un’applicazione. Un ambiente autosufficiente che non necessità di pubblicità.
Inoltre, con il lancio del nuovo iPhone 3.0, Apple potrebbe aprire la strada ad un ulteriore sviluppo di questo modello basato sulla vendita delle applicazioni. Una volta venduta un’applicazione, infatti, i programmatori possono vendere ulteriori contenuti direttamente dall’interno della stessa applicazione, senza dover ritornare all’AppStore. Ad esempio, se acquisto l’applicazione del New York Times per iPhone, e leggo tra le pagine del giornale una recensione su un disco o un libro, posso poi acquistarli direttamente con un click, senza dover uscire dall’applicazione. Una transazione nella transazione, quindi, che abbassa ulteriormente il costo mentale dell’acquisto.
Un panel on-line per un business model di successo
Sempre in tema di business model, dalle pagine del blog di Jeff Jarvis si apprende che la CUNY si occuperà di analizzare tre tipi di modelli allo scopo di trovare una soluzione all’impasse attuale: iper-locale, metro paper e contenuti a pagamento.
Jarvis ha più volte espresso la sua perplessità sulla riuscita dei modelli a pagamento, e non è il solo, sebbene vi siano più voci a sostenere che far pagare gli utenti per i contenuti offerti non solo sia possibile, ma anche necessario. Nonostante i propri dubbi, Jarvis sa che la bontà di un business model è valutabile solo dopo la suamessa in opera, e per fare ciò è prima necessario raccogliere il maggior numero possibile di informazioni e punti di vista.
Per questo che dal suo blog ha lanciato un’iniziativa che vuole coinvolgere tutti gli utenti, per sviscerare tutti gli aspetti dei modelli presi in esame, partendo proprio da quello a pagamento. Secondo Jarvis le domande fondamentali alla base di questa possibile strategia sono due:
Cosa supporterà il mercato? E quanto giornalismo sarà disposto a pagare? Prima di trovarvi una risposta, però, è necessario analizzare (anche con l’intervento degli utenti e degli addetti ai lavori) alcuni aspetti della questione, come ad esempio:
- Esperienza: è necessario valutare i dati effettivi di quegli editori che hanno adottato il paid-for model (New York Times, Wall Street Journal, Financial Times, Los Angeles Times, Economist), anche attraverso l’aiuto di chi ha lavorato a tali progetti e, magari, degli stessi editori.
- Modelli di pagamento: si pagherà per l’accesso al contenuto intero o parziale di uno o più siti su un determinato periodo di tempo, o si effettueranno micro-pagamenti per singoli articoli? Vi saranno contenuti premium o un accesso limitato a tutti i contenuti prima di pagarli e fruirne interamente?
- Prezzi: quanto bisognerà pagare per ognuna di queste soluzioni? Cosa ci insegna l’esperienza pregressa sulla sensibilità dell’utente verso i prezzi? Se fossimo disposti a pagare, per cosa pagheremmo?
- Costi di acquisizione: a quanto ammontano le spese di marketing necessarie per accaparrarsi nuovi acquirenti?
- Tasso d’abbandono: per calcolare i costi netti di marketing, è necessario sapere quanti utenti disdicono il proprio abbonamento.
- Audience: quale è il totale del ‘pubblico pagante’?
- Altri costi operativi: autorizzazione dalle carte di credito, servizi al cliente ecc.
- Impatto dell’advertising: si suppone che la pubblicità abbia un valore aldilà del paid wall, in virtù di una maggiore profilazione dell’utente.
- Raccolta dati: è possibile monetizzare i dati acquisiti dagli utenti?
- Impatto dell’audience e del traffico: è il punto cruciale della questione. Le entrate provenienti dai pagamenti supereranno la perdita di pubblicità scaturita da un eventuale minor numero di lettori, o la rendita della pubblicità differenziata tra utenti paganti e no supererà le entrate determinate dai pagamenti?
La lista stilata da Jarvis continuava, e l’aiuto e l’esperienza diretta degli utenti sono contributi ben accetti. Indubbiamente è un lavoraccio, ma qualcuno doveva pur farlo.