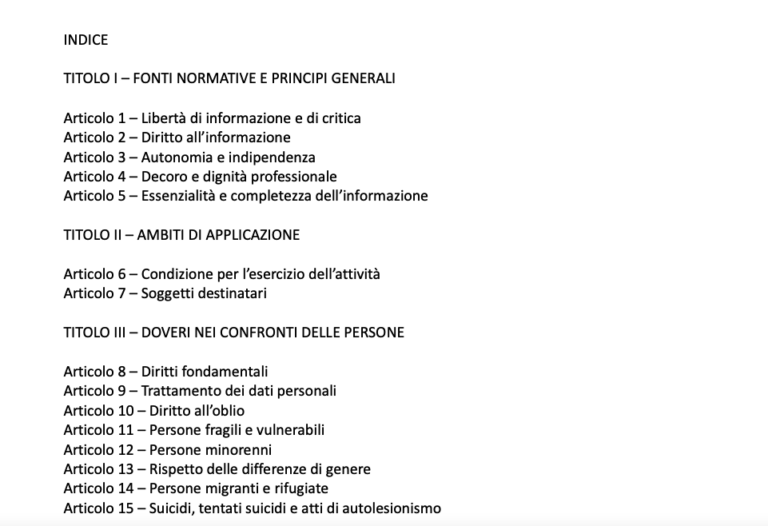Giornalismo e pubblicità , una miscela pericolosa
Più i media digitali si affermano e più le questioni etiche perdono terreno: lo denuncia in una sua Mondaynote Frédéric Filloux, a proposito di quanto emerge dal Rapporto “The Story so Far”, della Columbia School of Journalism, una recente analisi dello stato del giornalismo digitale contemporaneo – Nelle testate che hanno maggior successo, come l’ Huffington Post, vengono investite più risorse nella valutazione dell’ audience che nella creazione dei contenuti: una ‘’ossessione per i dati’’ che, sottolinea Filloux, ‘’viene pompata dalla cultura della pubblicità che ha finito per diventare dominante in internet’’ – In questo quadro, l’ etica giornalistica viene vista come un relitto del passato, tanto che ‘’oggi, ogni prodotto può, letteralmente, comprare recensioni positive in una blogosfera che, essendo senza un soldo, può cadere facilmente nella corruzione… nel mondo della tecnologia, ‘blogger influenti’ spesso significa ’blogger influenzati’
———-

Dangerous blend
di Frédéric Filloux
(MondayNote)
Qualche giorno fa la Columbia School of Journalism ha diffuso un Rapporto dal titolo “The Story so Far“ (il Pdf è qui). Per i fanatici dell’ informazione è come se il Vaticano pubblicasse un manuale di sessualità . In ogni caso si tratta di uno dei migliori studi sullo stato del giornalismo contemporaneo che sia mai stato scritto. Gli autori, Bill Grueskin, Ava Seave e Lucas Graves, analizzano nel dettaglio gli effetti di 15 anni di gratuità dell’ informazione su internet e le conseguenze di notizie disaggregate a pezzetti che perdono il proprio valore nel turbine dei social media. Nelle 143 pagine della Ricerca nessun rimpianto, nessuna lamentela,  nessun rimpianto: solo fatti e approfondimenti dello stato attuale dei media digitali. Un lavoro che è assolutamente da leggere.
Usando osservazioni ed esempi attuali, la ricerca fa rizzare i capelli quando delinea le opzioni per la futura economia dell’ informazione online.
Nelle testate che hanno maggior successo, come l’ Huffington Post, ad esempio, vengono investite più risorse nella valutazione dell’ audience che nella creazione dei contenuti. Come spiega il Rapporto, il gigante degli aggregatori di informazione giornalistica è costruito sulla base di un tracciamento continuo dei temi che possono intercettare il traffico maggiore; e a livelli di lettori, infatti, l’ HuffPo ora può competere con il New York Times.
L’ Huffington Post ha sviluppato anche una grande abilità nel rispondere velocemente ai dati sul traffico e gli utenti che riesce a registrare – cosa che rappresenta una componente cruciale nel successo del giornalismo digitale. Infatti, l’ analisi dei dati si è trasformata da un compito fondamentale per i settori finanziari di un’ azienda in una parte essenziale del lavoro di direttori, articolisti e designer.
In molte redazioni online che vanno a tutto gas – sottolinea la ricerca – i giornalisti devono continuamente tenere sott’ occhio sugli schermi le performance in tempo reale di articoli e titoli. Aggiornano continuamente l’ elenco di quello che viene cliccato e di quello che non viene cliccato; ognuno viene spinto a correggere il trend dei dati che lo riguarda. Inevitabilmente vengono inseriti degli incentivi, con dei bonus legati al rendimento che viene via via registrato.
Un tale tipo di ossessione per i dati viene pompata dalla cultura della pubblicità che ha finito per diventare dominante in internet: i ricavi sono strettamente legati al livello dell’uso degli occhi, visto che i media vengono prevalentemente pagati a CPM (costo per migliaia, di occhiate).
La Columbia Journalism School sfida indirettamente questo sistema citando il lavoro notevole di Matt Shanahan, che anima il blog Scout Analytics. Shanahan spiega che cosa succede nei siti web dei quotidiani di livello medio. I “fly-bys” (cioè gli internauti che guardano una pagina e poi se ne vanno altrove) rappresentano il 75% dei visitatori, contro solo il 4% dei veri fans. Ma il gruppo dei più fedeli produce il 56% delle pagine viste. “In generale, ogni fan genera un traffico maggiore di circa 50 volte di quello di un fly-by”, racconta il Rapporto.
Questo mostra come siano assolutamente devianti gli attuali sistemi di misurazione. L’ ossessione corrente per la metrica del ‘’Visitatore Unico’’ domina il mercato della pubblicità e quindi la competizione fra i siti di informazione. Questa fissazione incoraggia una sorta di ‘’corsa agli armamenti’’, con tutti i mezzi possibili (giochi, link fasulli, ecc.) fake url) in cui le testate giornalistiche sparano a zero per aumentare il numero dei loro ‘’VU’’ e per salire nella classifica. Ma è un modo di fare miope: i lettori fedeli – circa il 10%, che genera l’ 80% delle pagine viste – dovrebbe essere invece la misura della scelta.
In questa bassa cultura dei numeri, la Muraglia cinese che dovrebbe difendere il giornalismo dall’ influenza della pubblicità diventa penetrabile, poroso. Qui c’ è forse la parte più controversa del Rapporto della Columbia, in cui gli autori sembrano non particolarmente critici – o almeno non abbastanza – verso la crescita della commistione notizie/pubblicità . (Perché lo fanno? Questi accademici in fondo sarebbero tenuti ad esporre i fatti, le migliroi e le peggiori pratiche, e non a difendere una corporazione).
E i fatti parlano da soli.
‘’The Story so far’’ documenta l’ esperienza penosa dell’ Examiner.com, un sito comunitario basato su 72.000 ‘’articolisti’’ freelance pagati fra 1 e 7,50 dollari per ciascun migliaio di pagine viste. Non solo l’ Examiner deve vendere contenuti scontrandosi con un particolare contesto editoriale (ma tutti i media lo fanno) , ma deve disegnare quei contenuti tenendo conto dei bisogni della pubblicità . Per esempio, il sito incoraggia a scrivere di animali in vista di possibili champagne pubblicitarie per qualche linea di alimenti per animali prodotti dalla Procter & Gamble.
Sfocare la linea di separazione fra pubblicità e giornalismo sta diventando una pratica diffusa sull’ internet di oggi. Invocando lo sviluppo dei social media, i siti offrono ai marchi la possibilità di rivolgersi direttamente ai loro lettori attraverso i meccanismi della sponsorizzazione. Gestendo più di 4 milioni di commenti al mese, l’ Huffington Post è diventato, senza comunque nessuna sorpresa, il grande maestro di questo esercizio, invitando i brand a ‘’impegnarsi in una conversazione’’ con gli utenti e pagando naturalmente gli intermediari della conversazione. Il Rapporto cita in particolare Eric Hippeau, ex CEO dell’ HuffPo:
Eric Hippeau definisce questo approccio “trasformare i clienti in editori.†Gli inserzionisti, dice, non solo creeranno contenuti che aumenteranno il traffico, ma determineranno ‘’una grande diversificazione di ricavi’’ rispetto alla tradizionale vendita della pubblicità attraverso la misura delle pagine viste. (…) Secondo la sua vision, una volt anche le aziende cominceranno a interagire con I lettori in questo contest, saranno’agganciate’. ‘’Una volta che un marchio comincia questo processo, non si fermerà più. E questo sarà un grande beneficio per le aziende editoriali’’.
Allo stesso modo, Forbes mette a disposizione tutti gli strumenti digitali per pubblicare contenuti in qualsiasi modo adatto al web.
Ciò potrà far sobbalzare i giornalisti che si attendono una stretta separazione fra l’ aspetto editoriale e quello economic, ma Lewis DVorkin [Chief Product Officer di Forbes] vede questo sforzo come un sistema logico per trattenere quegli inserzionisti che sanno di poter creare contenuti digitali dovunque, attraverso siti we ed email. Etichettare i materiali come provenienti dagli inserzionisti aiuta a vaccinare le aziende dalla violazione della separazione Stato/Chiesa – dice DVorkin -, aggiungendo che l’ approccio di Forbes consente agli addetti al marketing di non essere più confinati nel ‘’ghetto’’ dei freelance specializzati in Redazionali (advertorial). Il material pubblicitario non viene ‘’lavorato’’ editorialmente da Forbes e appare sia online che su carta come “ForbesAdVoice.â€(…) L’ editoriale AdVoice sull’ edizione a stampa – limitato per ora a uno a numero – appare nell’ indice dei contenuti e può anche introdurre un eventuale articolo correlato. E sull’ online l’ editoriale online viene caratterizzato quasi con lo stesso rilievo dei principali contenuti giornalistici. .
DVorkin è un po’ ingenuo (o cinico, decidete voi) nella difesa di questa miscela. In un post del 2010 sosteneva la parità fra giornalisti professionali, esperti e uomini di marketing ponendoli sullo stesso livello:
Sul web, utenti con una approfondita conoscenza in settori specifici si confrontano senza timore con giornalisti professionali in possesso di minore esperienza nel campo. Addetti al marketing, esperti nel loro settore, sono diventati dei produttori di contenuti altrettanto rispettati in una società sempre più ossessionata dall’ Informazione.
Il Rapporto della Columbia è stato criticato per non aver preso abbastanza le distanze da queste pratiche, dando per scontato ed accettabile lo svanire dell’ idea della separazione fra ‘’chiesa e stato’’, (pubblicità /giornalismo, ndr). Gli autori suggeriscono poi che i giornalisti dovrebbero acquisire maggiori conoscenze dell’ evoluzione del mondo economico.
Io penso che su questo hanno ragione per due motivi: a) un giovane giornalista sa molto poco dell’ aspetto economico dei media, non può tenere gli occhi chiusi sul processo con cui gli editori monetizzano i loro prodotti; b) capire questi ‘’misteri’’ aiuterà a tenere una linea corretta sul piano dell’ etica: l’ innocenza non deve essere una trappola, ma nemmeno una scusa
A mano a mano che i media digitali si dispiegano, che i ‘pure players’ si rafforzano e crescono, le questioni etiche perdono terreno. Pensate alla recente controversia su Michael Arrington: il fondatore di TechCrunch era un ‘’capitalista mecenate’’ (‘’an angel investor’’) prima di saltare nel business dell’ editoria. Recentemente ha deciso di ricapitolare la sua attività di investitore nelle aziende tecnologiche e ha raccontato tutto in un post riepilogativo. Naturalmente, questa scelta ha scatenato una raffica di commenti e di polemiche da parte dei giornalisti che hanno avuto dei ruoli rilevanti nella vicenda. Elegantemente, in un post intitolato “The Tech Press: Screw Them All” Arrington sparge veleno, denunciando che, se per lui c’ era qualche conflitto di interesse, c’ erano anche quelli del noto giornalista esperto di tecnologia che ha per compagna una dirigente di Google, o di quell’ altro che  vive con un consulente di Facebook.
Ma lo stupore un po’ ipocrita di Arrington non è tanto sorprendente. I media digitali si sono sviluppati in un paesaggio in cui l’ etica giornalistica veniva vista come un relitto del passato. Oggi, ogni prodotto può, letteralmente, comprare recensioni positive in una blogosfera che, essendo senza un soldo, può cadere facilmente nella corruzione. Quando pianificano il lancio di un prodotto con un cliente, le agenzie di pubblicità spesso suggeriscono il dispiegamento di un ‘’esercito di blogger’’ (‘’blogger army’’, questo è il termine gergale) per diffondere il messaggio su blog e social network. Nel mondo della tecnologia, ‘’blogger influenti’’ spesso significa ‘’blogger influenzati’’.
Il Rapporto della Columbia School of Journalism apre uno spiraglio interessante sulla direzione in cui i media digitali vengono condotti. Il loro quadro economico è in una situazione di tale confusione che gli editori sono disperati per la mancanza di business model. In questa evoluzione l’ etica subirà probabilmente molti danni collaterali. I novizi questo lo devono capire.