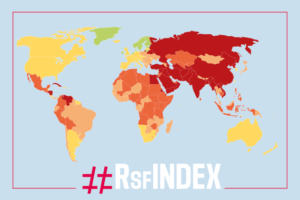Giornalismo investigativo. Leo Sisti: inchieste finanziate da fondazioni straniere, per garantire indipendenza e qualitÃ

Uno dei maggiori giornalisti italiani racconta la sua esperienza professionale e il suo costante ripudio della “casta giornalistica”. Il suo ultimo progetto, IRPI, è un esperimento al di fuori dei confini dei media tradizionali del nostro paese – In Italia, spiega, ‘’chi darebbe mai quattro o cinque mesi ad un giornalista per fare un’ inchiesta? Oggi i giornalisti devono farle in due o tre giorni. E’ un ritmo impossibile per un quotidiano. Per questo, IRPI sta occupando uno spazio che è libero, almeno nel nostro paese’’ –  E poi, aggiunge, i nostri quotidiani  ‘’oggi sono malati di politica: di politica del gossip piú sfrenato. Io non capisco questo giornalismo’’, non accetto questa ‘’fabbrica del gossip politico’’ – ‘’Trovatemi un politico che non voglia parlare: è sempre a tua disposizione, mentre il problema è far parlare chi non vuole’’
Â
di Daniele Grasso
Milano/Madrid – Cominciò alla fine degli anni ’60, all’ università , con il giornalismo musicale; passò dalla cronaca economica e giudiziaria e approdò al giornalismo investigativo per svelare, tra gli altri, i segreti della mafia siciliana e di Al Qaeda. Ed oggi, dopo più di 30 anni di carriera, Leo Sisti non è affatto stanco.
Questo giornalista d’ inchiesta con otto libri scritti e premi prestigiosi come l’ Investigative Reporters and Editors, ha fondato a gennaio l’ Investigative Reporting Project Italy (IRPI), un progetto per svolgere e promuovere inchieste giornalistiche internazionali, ispirandosi all’ esperienza maturata con l’ International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), di cui è membro dal 2000.
Sisti ci riceve nel suo studio milanese, un piccolo appartamento che trabocca di archiviatori colorati su cui spiccano i nomi di personaggi illustri della recente storia italiana. Nonostante sieda dietro ad una scrivania piena di ritagli di giornale, assicura che il giornalismo di oggi, lui, non lo capisce: “troppa politica e troppo gossip”.
 Con che idea nasce l’ IRPI?
Con che idea nasce l’ IRPI?
Irpi, più che come possibile struttura giornalistica, nasce come un esperimento. L’ obiettivo è fare grandi inchieste finanziate da fondazioni internazionali, evitando invece quelle italiane.
Â
E questo garantisce l’ indipendenza?
Io credo di sì. Abbiamo preso il modello dell’ ICIJ. Per ora siamo in nove, tre stipendiati ed altri freelance, tra fixer e collaboratori. Si lavora in italiano ed in inglese. Siamo nati a gennaio, ma abbiamo già pubblicato un’ inchiesta, Agromafia. La parte pubblicata fino ad ora tratta il sistema del pomodoro “made in Italy”, ma in realtà in gran parte cinese, che una grande azienda italiana vendeva in Inghilterra. L’ inchiesta è stata finanziata dal  Journalism Fund ed è stata venduta a The Guardian. Ed è lì che arriva il guadagno, perché i finanziamenti se ne vanno in viaggi ed hotel, anche se stiamo stringati: se si può, ci si fa ospitare da amici. Quando l’ inchiesta la vendiamo, i soldi si distribuiscono tra chi l’ ha realizzata.
Perché sui giornali non si trovano grandi inchieste?
Perché nessuno dará mai quattro o cinque mesi ad un giornalista per fare un’ inchiesta. Oggi i giornalisti devono farle in due o tre giorni. É un ritmo impossibile per un quotidiano. Per questo, IRPI sta occupando uno spazio che é libero, almeno in Italia.
Â
Ma l’ inchiesta sarebbe un’ investimento: perché sembra che nessuno voglia arrischiarsi?
Io ci ho provato a farlo capire, ma sembra impossibile. I quotidiani oggi sono malati di politica: di politica del gossip più sfrenato. Io non capisco questo giornalismo, non lo accetto. Il fatto è che ci sono molti giornalisti che scrivono di politica, ed ovviamente vogliono imporre i propri pezzi. Così si forma un meccanismo autoreferenziale. Se leggo la miliardesima intervista a Veltroni giro pagina: cosa ha da dire di nuovo? Leggendo i giornali (ed essendo giornalista sono obbligato a leggerli tutti) sembra che si tratti di fare “pubblicità ” a certi personaggi, che sono in scena da 20 o 30 anni.
Â
Si utilizza sempre più spesso il termine “casta”, per definire la classe politica. Esiste questo status anche nel giornalismo?
Io credo che esista una casta giornalistica che vuole mantenere questo interesse verso la politica. E questo si traduce in pubblicità gratuita per il politico di turno. Certe interviste non si giustificano: perché si fanno? Nella maggior parte dei casi si tratta di una sorta di patto tra giornali e politici: quando concedi l’ intervista al politico, sai che poi ti darà altre informazioni con cui tirar fuori nuovo gossip politico. Ma pensandoci bene, non ha senso. Ogni mattina sai già come verranno impaginati i quotidiani, perché sai già come la pensa uno, come racconta la notizia: non posso leggere gli stessi articoli fatti dalle stesse persone.
In ogni caso, il nostro compito è quello di essere watchdog, e farlo dai giornali. Se non lo si fa, se non si denuncia, meglio lasciare il mestiere. Altrimenti si fa propaganda.
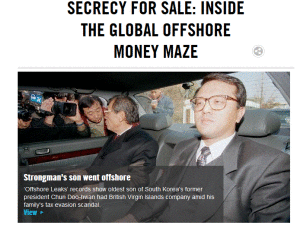 Con l’ ICIJ avete publicato inchieste su argomenti che normalmente non trovano spazio sui giornali, neanche a piccola scala: il tonno rosso, il contrabbando di sigarette, addirittura i paradisi fiscali. Può essere un problema lo scarso interesse pubblico?
Con l’ ICIJ avete publicato inchieste su argomenti che normalmente non trovano spazio sui giornali, neanche a piccola scala: il tonno rosso, il contrabbando di sigarette, addirittura i paradisi fiscali. Può essere un problema lo scarso interesse pubblico?
Fino ad un certo punto. Se hai belle inchieste, sfondi. Pensate a Offshore Leaks, ICIJ l’ ha venduta in tutto il mondo. Certo, non è facile averle, le inchieste, bisogna costruirle. E con i segreti della professione: determinazione, onestà intelletuale e grande curiosità . Se uno non è più curioso meglio che smetta, o finisce a fare l’ insaccatore di notizie altrui.
Come si costruiscono le grandi inchieste, a partire dalla relazione con le fonti?
Bisogna faticare, tampinare, stare addosso alle persone. Ma non attaccati al telefono o davanti al computer. La notizia si fa con il contatto umano, le fonti bisogna trattarle, convincerle. Si parla con la gente e si risponde quando dicono cazzate. Questo è il mestiere. E questo non succede nella politica, dove è più semplice. Trovami un politico che non voglia parlare: è sempre a tua disposizione, mentre il problema è far parlare chi non vuole. Durante una conferenza a Washington chiesi a Seymour Hersh quale fosse il suo segreto. Rispose: “io chiamo le mie fonti alle sette del mattino: le butto giù dal letto”.
Ha iniziato a lavorare in un giornale nel 1974. Che ruolo hanno giocato, nel suo mestiere, i progressi tecnologici?
Pensando ad OffShore Leaks, direi che negli anni ’70 non c’erano gli hard disk di oggi. Però, anche qui, si tratta di un hard disk filtrato, e l’ importante rimane il suo contenuto, che costituisce una forte denuncia. Forse 30 anni fa era un po’ più facile avere il materiale, ma l’ ho tirato fuori ugualmente. Quello che continua a contare sono le fonti. Il lavoro di filtro può essere il primo passo, ma poi dipende da quello che raccontano le fonti e da come uno concatena gli indizi, tassello dopo tassello.
In Italia ha fatto inchieste sulla mafia: cosa implica?
La mafia è un mondo a parte. Si hanno informazioni che vengono direttamente dai mafiosi, e nella maggior parte dei casi si tratta di pentiti. Quando si sa che uno è pentito, il problema è avvicinarlo. E una volta che ci sei, è anche tutto diverso dal mondo, per esempio, della corruzione. In Sicilia, poi, c’ è una prevenzione micidiale, nessuno dice nulla. Ti mandano messaggi cifrati. Una volta, dopo aver pubblicato un libro sulla mafia, mi chiamò un grande mafioso per dirmi di essere disponibile a raccontarmi tutto, dal suo punto di vista, sul mondo mafioso: probabilmente gli serviva per far capire, nei suoi giri, cosa sapeva e cosa voleva lui. Ma anche con la mafia, la chiave è creare un rapporto privilegiato con la fonte.
È mai stato minacciato o denunciato?
L’ arma che spesso si usa è la denuncia per diffamazione. Ma in politica non mi fa paura, perché spesso si muove nel campo dell’ opinione e si fa tanto rumore per nulla. Il problema a volte è con le querele che arrivano anche quando il giornalista usa documenti giudiziari: chi le fa è ricco, paga, non gli importa perdere. E questa è intimidazione, in fin dei conti.
Poi ci sono casi più concreti: una volta, mentre ero in tv a parlare di una mia inchiesta su una persona in concreto, mia moglie ricevette una chiamata. “Lei è la moglie di Leo Sisti? Gli dica che è un figlio di puttana”, le dissero. E in questo modo ti avvertono di stare attento. Sono le più pericolose.
Altro tema delicato che ha trattato è il finanziamento di Al Qaeda, come si legge nel libro “A caccia di Bin Laden” (Baldini Castoldi Dalai Editore, 2004). In quel caso, come si mosse?
In un modo totalmente diverso. Nella primavera del 2001 arrestarono, a Milano, alcune “cellule dormienti” che lavoravano nell’ ombra per AlQaeda. Pubblicai le intercettazioni telefoniche su L’ Espresso. E arrivò l’ 11 di settembre: il giorno dopo, passai quel materiale all’ ICIJ. Da lì inziai ad essere contattato da media americani che volevano saperne di più. Capii dunque quanta attenzione suscitava l’ argomento. Fu però solo nel 2003, quando scoppió la guerra, il 20 di marzo, che volai a Washington e dissi ad alcuni giornalisti amici che volevo scrivere un libro su Bin Laden. Mi presentarono ad una serie di persone, fino al segretario al Tesoro del governo di allora, che si occupava del finanziamento di Al Qaeda. Recuperai e raggruppai quindi le inchieste giudiziarie sulle cellule di Al Qaeda in Spagna, Francia, Germania, Inghilterra e Stati Uniti. In questo modo riuscii a raccontare la caccia a Bin Laden, gli indizi, i buchi nella sicurezza della CIA. E’ un’ inchiesta diversa, ma il fulcro sono sempre indagini giudiziarie. Con quelle si citano documenti, ed è un materiale sempre sicuro.
Si parla quotidianamente del futuro dei giornali. È d’obbligo chiederle la sua opinione al rispetto.
Credo che dipenda dai tipi di giornalismo. Io trovo che la cronaca giudiziaria sia quella che sempre resiste.
Per quanto riguarda Internet, sembra che ormai si stia mangiando tutto lo spazio del cartaceo. Quindi credo che la maggior parte dei quotidiani che vogliano mettere le notizie (quelle vere) online lo faranno con modelli simili al paywall del The New York Times. E io sono d’ accordo. Poi ci sono campi, come il Data Journalism, che sembrano rappresentare davvero il futuro, almeno così sembra osservando gli Stati Uniti.
In quanto a noi, ci siamo buttati nell’ IRPI, che non é la soluzione a tutto questo: è piuttosto un tentativo di salvare i freelance.