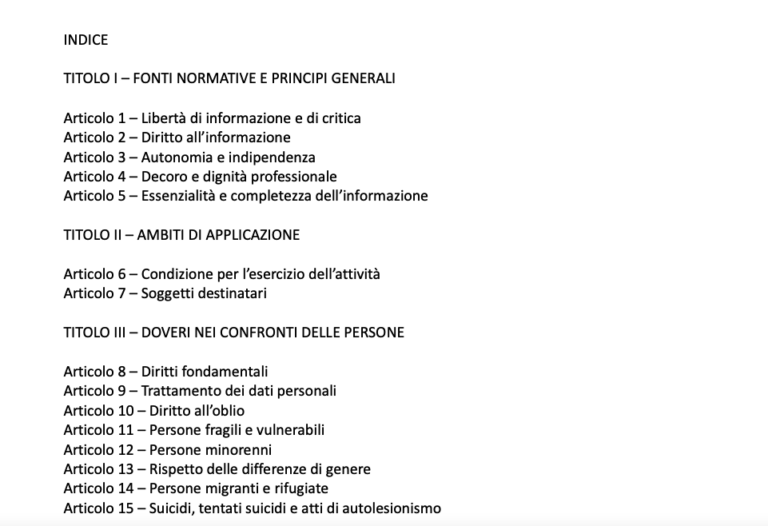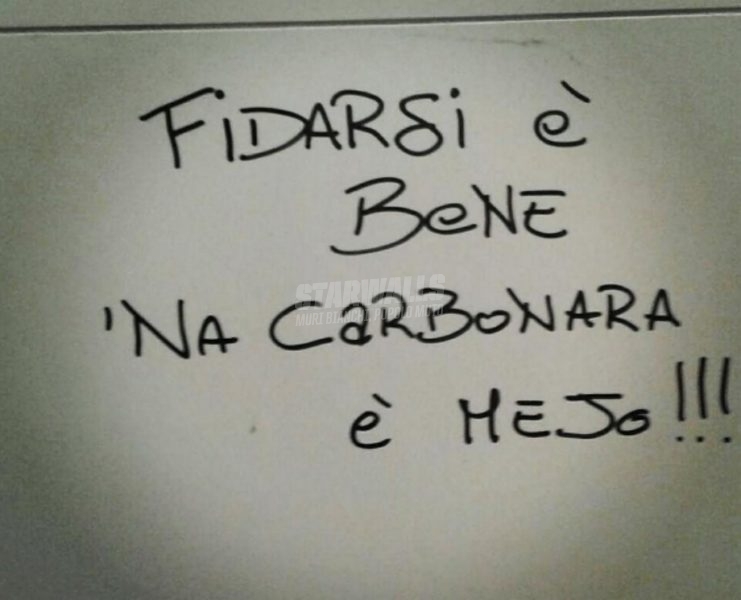
Fiducia, giornali, capitale sociale e altri accidenti
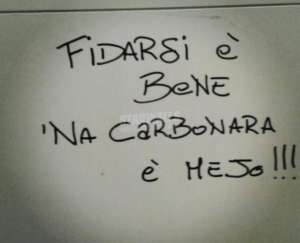 Come possono le testate giornalistiche ricostruire la fiducia con i propri lettori?
Come possono le testate giornalistiche ricostruire la fiducia con i propri lettori?
Dato che, senza fiducia tra “chi scrive†e “chi leggeâ€, l’ecosistema informativo non sta in piedi, quella della fiducia è questione cruciale per il futuro del giornalismo e dell’editoria; e, considerato il ruolo sociale del giornalismo , proviamo a ragionarci su anche per provare a migliorare le prospettive per il futuro del nostro Paese
Io credo che una delle più importanti cause di fallimento di numerosi tentativi di salvataggio delle testate giornalistiche sia il loro guardare più agli interessi dell’Editore (che, mediamente, del ruolo sociale del giornalismo, vuole servirsi esclusivamente per “far soldiâ€) che agli interessi del lettore, il loro essere una questione più finanziaria che sociale (un esempio su tutti, un po’ datato, forse, ma molto immediato dal mio punto di vista: la notizia della fusione tra Itedi e Gruppo Espresso è stata data sui siti de la Stampa e di Repubblica nelle rispettive sezioni economiche).
Cominciamo quindi con l’invertire le priorità : c’è da salvare una Nazione, non l’industria Editoriale (quest’ultima si può salvare. Ma solo di riflesso).
Considerando che il Capitale Sociale è una buona misura della fiducia, nel tentare altre vie per uscire dalla crisi, la questione posta all’inizio diventa: come si può incrementare il Capitale Sociale delle relazioni tra giornalisti e lettori?
È inutile dire che un conto è mirare alla massimizzazione dei profitti dell’Impresa Editoriale, un conto è puntare alla massimizzazione del Capitale Sociale.
Io propongo di percorrere la seconda strada.
La teoria (o almeno una delle tante formulate in materia) prevede che il Capitale Sociale aumenti quando si stringono relazioni tra persone appartenenti a gruppi eterogenei. La soluzione per stimolare la crescita di Capitale Sociale sta perciò nel favorire tale eterogeneità incrementando le dimensioni e la “cifra†delle relazioni, agendo tanto sul piano culturale quanto sul piano tecnologico/infrastrutturale.
Quando parlo di piano tecnologico/infrastrutturale non mi riferisco semplicemente a Internet. Nel senso che Internet, in sé, non è la soluzione del problema. Chi si approccia così alla questione, veste i panni del Pirata e dà ragione ad Eugeny Morozov . Che comunque, a mio avviso, tanto torto non ha.
Ci sono infatti almeno tre aspetti su cui lavorare sul “tema della digitalizzazioneâ€:
(1) digital divide:
per mettere sullo stesso piano i Cittadini, bisogna in prima istanza garantire a tutti l’eccesso alla rete. Stefano Rodotà  aveva più volte posto la questione su un piano legislativo. Sarebbe utile riprendere il discorso.
(2) neutralità della Rete:
dopo quello che è appena successo negli Stati Uniti, dove – come dice Michele Mezza : “le lancette sono tornate indietro di almeno trent’anni†io penso – cito ancora Mezza – che si debba “aprire la battaglia delle idee per creare uno spazio pubblico e innovativo nel cuore di Internet“; poco importa, a mio avviso, quale sarà la reazione degli OTT (“Google, Facebook, Amazon a questo punto non possono più nascondersi dietro la retorica del “don’t be devil”, devono dichiarare da che parte staranno: con la rendita o con l’innovazione?”): occorre che questa battaglia inizi ora; in Italia abbiamo una occasione irripetibile con la campagna elettorale per le Politiche: questo tema non può rimanerne fuori (oppure c’è qualche partito che ha interesse a proteggere le telecom per il loro poter garantire “database per fare la propaganda e la comunicazione politica?”
(3) neutralità degli algoritmi:
in questi mesi qui su LSDI abbiamo  cominciato a spostare in avanti il fronte di quest’altra fondamentale battaglia: era stato Eli Pariser ad aprirlo con il suo “The Filter Bubble†chiedendo alle Aziende (si, ancora le OTT) una maggiore trasparenza sul funzionamento degli algoritmi su cui si basano le loro applicazioni. E’ ormai evidente che bisogna spingersi più in là : ancora Michele Mezza: “L’algoritmo deve iniziare a essere uno spazio pubblico​. I nuovi grandi editori mondiali, ossia Facebook, Google, Amazon, ecc. devono rendere i loro algoritmi uno spazio pubblico. Giornalismo come sapere sociale, condiviso e professionalmente testato, passando per la lotta contro le fake news. Ma un algoritmo, chiunque lo abbia elaborato e formattato, fosse anche il più insignificante operatore debuttante, privo di ogni potere e ambizione, deve sottostare a regole di trasparenza, negoziabilità e modificabilità . Per poter garantire l’autonomia e la sovranità di tutti i soggetti dell’ecosistema della rete“.
La Dichiarazione dei diritti in Internet rappresenta un buon punto di partenza. A mio parere, però, per restare nel perimetro appena tracciato, essa è uno strumento ancora troppo debole:
(a) perché penso che sul Diritto di accesso (art. 2) e sul Principio di neutralità della rete (art. 4) si dovrebbe alzare l’asticella e agire anche sul piano normativo;
(b) perché ritengo necessaria una trattazione più ampia ed incisiva del tema dell’Algoritmo (per ora presente in un comma dell’art. 9), valutando anche qui l’eventualità di percorrere vie legislative.
Cosa vuol dire, poi, agire sul piano culturale? Significa modificare le pratiche delle relazioni tra cittadini in Rete. Nella pratiche tra Giornalisti e Lettori occorre per esempio creare un nuovo patto sociale in cui siano riconosciuti i nuovi ruoli e le nuove responsabilità derivanti dalle piattaforme sociali online. Cerchiamo di individuarli.
(a) per il giornalista-moderatore uso gli argomenti di Leila Zoia che così ha scritto su LSDI qualche tempo fa:
“nella nuova dimensione digitale il lavoro giornalistico si esplicita in molti e diversi modi; dal cercare riscontri e pareri da parte degli utenti attraverso la lettura dei commenti al pezzo; dal cercare interazioni con gli stessi, rispondendo o facendo rispondere alle parti interessate ai commenti espressi; raccogliendo spunti ecc. Se il commento, però, esprime un discorso d’odio, come si devono comportare i giornali online per arginare questo fenomeno?â€.
La risposta alla domanda posta da Leila Zoia è nel rapporto “L’odio non è un’opinione – Ricerca su hate speech, giornalismo e migrazioniâ€. Bene, io ritengo che il giornalista debba declinare il ruolo di “moderatore delle conversazioni†in un modo nuovo. Perché l’hate speech, il Capitale Sociale, lo demolisce.

(b) per il lettore-contributore, invece, cito uno dei punti del codice etico, promosso dall’ONA (Online News Association) di standard e pratiche di utilizzo dei contenuti creati dal pubblico:
“Giving due credit to the owner of the content providing that consideration has been given to potential consequences, including their physical, mental and reputational well-being.†Ottimo argomento, questo, insieme con le conclusioni di alcuni interessanti studi su modelli di “microguadagno sociale per pagare le notizieâ€Â per sostenere una qualche forma di riconoscimento al lettore del ruolo attivo nella creazione di conoscenza che, quindi, non è più prerogativa del giornalista.
Ovviamente, nella costruzione di uno scenario che vuole seriamente mettere il cittadino al centro, non perdo di vista l’aspetto economico. Su questo tema ritengo che la quantità di Capitale Sociale circolante nelle relazioni tra “chi scrive†e “chi legge†possa essere un buon misuratore economico del lavoro del giornalista e del contributo del lettore (senza dimenticare – è il caso di sottolinearlo, viste le giuste battaglie che si stanno facendo per l’equo compenso – le professionalità in gioco).
Ci sono tanti modi per mettere in moto un simile meccanismo e, se si rimane nell’ambito dei metodi tecnologici e culturali per produrre e discutere contenuti, sono convinto che lo Stato, dopo un percorso che – per quanto detto – non può che essere politico, possa e debba fare la sua parte.