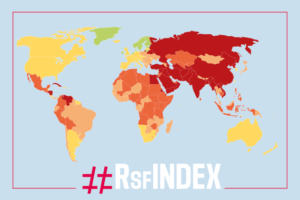Il giornalismo è morto, viva il giornalismo
 In realtà a morire sono ancora e sempre i giornalisti, quelli veri, che per riuscire a documentare la realtà , quella più complessa e non raccontabile se non attraverso le informazioni raccolte sul campo, finiscono vittime dell’ ennesimo conflitto.
In realtà a morire sono ancora e sempre i giornalisti, quelli veri, che per riuscire a documentare la realtà , quella più complessa e non raccontabile se non attraverso le informazioni raccolte sul campo, finiscono vittime dell’ ennesimo conflitto.
Il giornalismo non muore ma aggiorna le proprie regole, o almeno dovrebbe, in funzione delle novità nella fruizione, raccolta, diffusione delle notizie.
Il giornalismo italiano invece – quello istituzionale – non si aggiorna.
di Marco Renzi
Algido, monolitico, racconta a se stesso di una professione imbalsamata, fatta di privilegi e privilegiati, arroccati su indifendibili posizioni di comodo e non di principio, da aver perso completamente di vista la realtà , unico soggetto cui riferirsi e sottomettersi, nel racconto dei fatti, per svolgere compiutamente il proprio mestiere di giornalisti.
Il giornalismo italiano, quello delle istituzioni che governano la professione all’ italiana, è ”sconvolto” da una riforma sulle libere professioni che con il giornalismo non ha nulla a che vedere: non credo che abolire i listini possa significare alcunchè per le istituzioni giornalistiche né per almeno 25.000 dei loro iscritti che denunciano meno di 5.000 euro l’anno di reddito.
Negli ultimi giorni ho trovato in rete tre diverse posizioni sulla professione giornalistica, tre modi di intendere questo mestiere che vorrei condividere, tre spaccati significativi di un Paese che si spacca con essi.
La prima, da ascrivere all’ indifendibile posizione delle istituzioni professionali sclerotizzate, è contenuta nella dichiarazione resa a margine di un convegno sul futuro della professione dal segretario dell’ Ordine dei giornalisti del Piemonte, Paolo Girola:
 Il complesso dell’informazione locale è insidiato da una gran massa di informazione online: internet, social network. Un’informazione che non da reddito, che diventa sostituiva, che molto spesso devo dirlo è un’informazione fatta da dilettanti di basso profilo anche, di qualità professionale assente Che pero da l’impressione al pubblico di restare comunque informato anche se non accede ai tradizionali mezzi di informazione. Questa massa di informazione gratuita ovviamente mette in crisi le aziende che invece devono retribuire i loro dipendenti.
La seconda è apparsa sul blog personale di una giornalista che si chiama Elvira Pollina:
Il processo di verifica delle fonti e delle veridicità delle informazioni è il motivo per cui ha ancora senso il giornalismo professionale, di mestiere, o insomma il giornalismo in se’, chiamatelo come volete, che il mezzo sia l’agenzia, la carta, il web. Perché mai io dovrei pagare per una cosa che posso leggere prima su Twitter, si chiedono i talebani del web che sentenziano la morte del giornalismo professionale? A parte il fatto che i twitteri spesso non fanno che rilanciare notizie prese dai siti web e quotidiani online che a loro volta le riprendono dalle agenzie di stampa (nota polemica #6), la questione è un’altra. Twitter è una miniera d’informazioni e spunti, può metterti in contatto con fonti di prima mano, ma questo non prescinde dal verificare, dal cercare conferma.
La terza posizione di principio l’ ho estratta da un altro pezzo, diffuso da valigia blu nei giorni scorsi, e scritto da un ‘altra giovane giornalista, Valeria Gentile. E’ una riflessione talmente bella e significativa che devo riportarla integralmente.Buona lettura e grazie a tutte le Elvire e le Valerie e ai professionisti seri di cui il nostro Paese è stranamente ma ostinatamente ancora ricco!
Sono andata via di casa a diciannove anni, dopo il diploma linguistico e qualche dramma familiare in valigia. Ho vissuto a Firenze per laurearmi in Media e Giornalismo, ho vissuto due anni a Roma collaborando con festival, riviste, agenzie di comunicazione, case editrici. Ho viaggiato come reporter in Europa, Medio Oriente, Africa e Asia. Ho dormito e mangiato per terra con i bambini in Senegal, mi sono lavata nei bagni delle palestre abruzzesi con le donne terremotate delle tendopoli. Ho girato da sola nell’infinita metropolitana di Tokyo, ho passato i checkpoint israeliani a Ramallah, ho scalato col vento gelido di gennaio la Grande Muraglia Cinese. Sono salita su mulini olandesi e torri taiwanesi, sono entrata nella pancia dell’enorme Buddha di bronzo sulla costa giapponese, ho assistito ai lanci dai tetti di soldati mangiatori di serpenti in Libano, ho guidato una zattera di bambù sul fiume Li. Ho ventisei anni. Si potrebbe dire che io sia coraggiosa. Ma ancora più di questo, sono sarda.
Ogni giorno della vita è una lotta in cui le mie radici sono alleati e nemici, armi e talloni d’achille. Sono tornata per scelta a vivere nella mia isola perché tutto il mondo non basta a contenere l’amore e la gratitudine che provo verso questa terra. Credo nella vita e nel mio futuro perché la Sardegna mi insegna ogni giorno i suoi miracoli senza vergognarsi di essere onnipotente. Finché poi arriva un giorno in cui metti tutto in discussione. Arriva un super resort di lusso fondato da milanesi e altri italiani, che sulla mia isola ricopre venticinque ettari di parco in cui ci sono ventun ristoranti di lusso, quattordici bar, otto alberghi cinque stelle più diverse suites e qualche centinaio di bungalow, nonché children city, leisure land, sport academy, discoteca, spiaggia privata e tanto altro, dove una notte per una persona non costa meno di seicento euro. Arriva proprio quando meno me lo aspetto, mi contatta tramite Linkedin, mi offre un lavoro di gestione della comunicazione online e offline. Il che vuol dire comunicati stampa, fotografie, video, gestione della presenza e della reputazione sul web.
Passo il primo colloquio telefonico, la Media Relations & Events Manager mi adora e “caldeggia la mia candidaturaâ€. Passo anche il secondo colloquio in carne ed ossa, quello con il Sales & Marketing Executive Manager. Mi dice che ho un curriculum anomalo, che “mi sono fatta il mazzo†e mi porta a farmi conoscere al General Director che è anche socio, ai piani alti insomma, dove si parla a voce bassa e si tiene anche la testa, bassa. Primo e secondo colloquio, poi test individuale per il percorso di selezione, ma i manager ormai mi presentano dicendo “lei è, si occuperà diâ€. Ma non si accorgono che loro non hanno passato il mio, di colloquio. Il luxury resort numero uno mi contatta via Linkedin, mi offre un lavoro, mi scomoda, mi prepara a lasciare tutto quello che ho per trasferirmi a vivere dentro il resort, a non avere mai un giorno o un’ora libera, per fare la comunicatrice tuttofare, in un’industria dello svago di lusso che è una gabbia d’oro finto, in cambio di un contratto a progetto di sei mesi per settecento euro al mese.
E allora ripenso alle nuove tendenze del futuro che vogliamo, il futuro sostenibile di cui tanto ci riempiamo la bocca. Ripenso alla manifestazione della Consulta dei Movimenti di stamattina a Nuoro dove Gavino Sale ha detto una cosa semplice e vera: noi sardi siamo poveri perché regaliamo le nostre ricchezze. Ripenso alle mie amiche laureate che lavano scale per cinquanta euro alla settimana, alle sette donne che hanno fatto lo sciopero della fame, ai padri che non sanno come dare da mangiare ai figli per colpa delle trame marce di questo sistema mortificante. In loro onore e in loro nome, in nome della loro dignità , io rifiuto l’offerta e vado avanti, a testa alta. Rifiuto, declino, non accetto, respingo, boccio, dico di no, a questi signori tristi che hanno perso completamente ogni contatto con la realtà . Ho ventisei anni. Si potrebbe dire che io sia coraggiosa. Ma ancora più di questo, sono sarda.